L’ANGOLO DEDICATO AL LIBRO
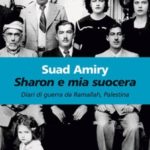 Sharon e mia suocera
Sharon e mia suocera
di Suad Amiry
Scritto dall’architetta palestinese Suad Amiry è stato pubblicato in Italia nel 2003. Nel 2004 ha vinto il premio Viareggio.
Una storia ironica, acuta, sarcasticamente realista sull’occupazione israeliana della Palestina. Sharon è una donna istruita, briosa e intelligente che descrive, in un diario giornaliero, i piccoli e grandi contrattempi del vivere nel disastroso scenario mediorientale. Lucida e realista Sharon si ritrova a dover convivere con la suocera, Umm Salim, che, nonostante la brutale occupazione, reagisce mantenendo inalterate le sue abitudini, orari, buone maniere e petulanti richiami.
Di seguito un brano del libro:
«Non ero in vena.
“Ci cacciate da Jaffa e poi vi chiedete come mai siamo nati da un’altra parte!”
Furono le prime parole che mi uscirono di bocca quando cominciai a rispondere alla prima di una lunga serie di domande rivoltemi dall’addetto alla sicurezza israeliano all’aeroporto di Lud, Tel Aviv.
Giuro che non ero in vena.
Erano le quattro e mezzo del mattino di una calda giornata estiva del 1995. Le quasi cinque ore di volo da Londra mi avevano ridotta uno straccio e volevo solo correre fuori dall’aeroporto in cerca di Ibrahim, venuto fin da Ramallah a quell’ora impossibile unicamente per recuperarmi. Che tesoro!
Va detto che la mia ansia e la mia irritazione aumentarono quando la giovane donna al controllo passaporti fece scivolare un cartellino rosa nel mio passaporto palestinese. Io, ovviamente, non ho alcun problema, né con il rosa, né con il fatto di essere palestinese. Ma in quel preciso momento, l’unica cosa che desideravo era un cartellino bianco. C’ero già passata molte altre volte: rosa significava automaticamente almeno un’ora in più o giù di lì in compagnia degli addetti alla sicurezza dell’aeroporto.
Non avete idea di quanto desiderassi un cartellino bianco, questa volta. Non ero proprio in vena.
“Come mai è nata a Damasco?” ripete il funzionario, evidentemente non contento, né soddisfatto, della mia risposta impulsiva.
Non ero in vena di raccontare all’addetto alla sicurezza di come, nel 1940, mio padre, venuto a Beirut da Jaffa, fosse rimasto folgorato alla vista di mia madre, originaria di Damasco. Lei aveva diciotto anni, lui trentatré. Lui si era laureato all’Università americana di Beirut, circa dodici anni prima, lei frequentava ancora il Syrian Protestant College.
Nel momento in cui mise piede nel grandioso cortile del palazzo dei Jabri, nel cuore della vecchia Damasco, e si rese improvvisamente conto di quanto fosse ricco il padre della ragazza, un noto mercante, il sogno di sposare quella donna di stupefacente bellezza, alta e dagli occhi verdi, cominciò a vacillare. A torto, perché quel sogno finì con il realizzarsi: altri, molti altri si sono infranti, poiché insieme hanno vissuto una vita tormentata.
Non ero in vena di raccontargli che, nel dicembre 1978, mio padre era morto d’infarto a Praga, mentre partecipava a un convegno di scrittori. Emile Habibi, che aveva passato la serata con lui, era stato l’ultimo a vederlo.
Non ero in vena di informare l’addetto alla sicurezza israeliano che, ogni volta che restava incinta, mia madre andava a Damasco a dare alla luce il bambino. Nel 1943, nel 1944, e poi nel 1949, era andata da Gerusalemme a Damasco per mettere al mondo le mie sorelle, prima Arwa (che oggi fa la psicologa e vive ad Amman), poi Anan (che oggi fa la sociologa e vive in America), e molto più tardi mio fratello Ayman. Si era trasferita da Amman a Damasco anche in occasione della mia nascita, due anni dopo. Non volevo ammetterlo, perché non avrebbe fatto altro che complicare le cose, aumentando senza alcun dubbio i timori per la sicurezza di Israele dell’addetto ai controlli. Il che, va da sé, avrebbe prolungato l’interrogatorio.
“È mai vissuta a Damasco?” chiede l’addetto alla sicurezza.
“No”, rispondo e più concisa non potevo essere.
Non ero in vena di dire all’addetto ai controlli che fino all’età di diciotto anni, quando lasciai Amman per studiare architettura presso l’Università americana di Beirut, quella stacanovista di mia madre, proprietaria di una tipografia e di una stamperia, ogni estate non vedeva l’ora di liberarsi dei suoi quattro figli. Non appena cominciavano le vacanze estive, ci mandava a casa dei suoi genitori a Damasco e dei suoi parenti a Beirut. Mio fratello Ayman ed io eravamo felicissimi di trascorrere parte delle vacanze insieme alle nostre zie nubili: Nahida e Suad (da cui ho preso il nome), che viziavano in modo vergognoso sia noi sia le mie due sorelle adolescenti. Ci portavano a cogliere le ciliegie nella casa di villeggiatura estiva di zia Farizeh, a Zabadani. Ogni venerdì aiutavamo le zie a trasportare cibo e angurie, in vista di uno spuntino in uno dei tanti ristoranti lungo il fiume Barada (colmo di cocomeri messi in fresco), nel lussuoso quartiere di Dummar.
Uno dei punti culminanti delle nostre vacanze estive era la Fiera internazionale di Damasco, dove zia Nahida ci comprava quelli che riteneva fossero i prodotti russi più nuovi: una matrioska di legno per me e macchine e aeroplani di legno per mio fratello Ayman. Quando eravamo a corto di idee, zia Nahida ci portava a fare una passeggiata nell’affollato suq El-Hamadiyyeh, dove placavamo la nostra sete con il gelato al pistacchio e alla gomma arabica della gelateria Bukdash. A distanza di quasi quarant’anni, sento ancora il gusto della gomma arabica».


